Questo pezzo è apparso originariamente su ZYZZYVA n.115, primavera/estate 2019
Quando la scena si apre, mi trovo sulla banchina nella stazione della BART, all’aperto e nel bel mezzo di una superstrada rumorosa, davanti al binario del treno per San Francisco. La banchina si trova al secondo piano da terra. La città è a malapena visibile sulla sinistra, grattacieli di madreperla su una Oz galleggiante. Le carrozze mi sfrecciano davanti e dietro, verso la mia destinazione o su per le colline della East Bay sulla destra, dove la nebbia incombe sulla tetra vegetazione. Giù in fondo, oltre le corsie d’auto, le cime degli alberi danno l’illusione che la struttura in cemento, grande abbastanza sia per la superstrada che per il treno, sia sospesa.
È la prima volta che lavoro con questo regista giapponese. Ti dirò tutto quel che ho imparato. Il traffico fa da sfondo alla mia immobilità. In un film d’autore, in cui il tempo scorre disteso, sereno, non mi agiterei nemmeno su un treno della metropolitana di Tokyo pieno zeppo di persone. Il regista non ha alcuna fretta di farmi arrivare in città per mandare avanti la trama. Mi concede il tempo di aspettare, di infilare l’abbonamento nella tasca esterna della borsa e far scorrere lo sguardo su e giù per il binario.
Visto che tutti abbiamo una storia, potrei essere una donna di qualsiasi età, persino un’anziana che cammina a piccoli passi, anche se, come spesso accade, vado per i trenta. Sono perfettamente a mio agio da sola, e non come se mi mancasse un compagno. Non tengo stretta la borsa, né mi avvicino ad altre donne. E tu, il pubblico, non devi squadrare con sospetto i personaggi sulla banchina, neanche l’uomo trasandato con indosso un sacchetto di plastica per far fronte alla pioggia improvvisa. La pioggia in sé non sarebbe significativa, un indizio che il film sarà triste. Sarebbe un caso della vita, di quel giorno. E domani è un altro giorno.
Sai che sono la protagonista perché la cinepresa torna pacatamente su di me, e non perché sia vestita in modo diverso o abbia un aspetto più affascinante delle altre persone nell’inquadratura. Anche se avessi una pelle perfetta e lunghi capelli lucenti, indosserei un berretto o una divisa. La cinepresa non indugerebbe lascivamente sul mio viso. Il mio sguardo non rivelerebbe quanto mi senta vulnerabile, se così fosse. Non guardo diritto verso la cinepresa. Potrebbe esserci un accenno, nel modo in cui sposto la borsa, del fatto che potendo scegliere sarei altrove, ma non è un peso. Non c’è alcun sospiro di impazienza.
Potrebbe volerci qualche istante prima che parta la colonna sonora e, anche allora, forse si limiterebbe al fruscio delle auto sull’asfalto bagnato e alle risatine delle studentesse, se ce ne fossero. Ho gli auricolari, ma non nelle orecchie, tranne quando c’è della musica. Se c’è della musica, potrebbe essere del jazz anni Cinquanta o musica classica occidentale, come in un romanzo di Murakami. Oppure dell’elettronica. Non sarebbe una «hit» o «la nostra canzone». Non ti darebbe fastidio, se non la riconoscessi. Non ti aspetti di riconoscere subito questa persona, l’«io» sulla banchina, né di essere intrigato dalle mie scelte. Da me ti aspetti che sia sincera. Io su di te non ho alcuna aspettativa, perché sono il personaggio di un film.
Alla fine il treno arriva. È passato abbastanza tempo da farci sentire entrambi sollevati, benché tu sia ancora in ansia per me: vuoi che viva un’avventura e l’ideale sarebbe che trovassi l’amore. Osservi le persone nella mia carrozza in cerca di possibili candidati. Parlano molte lingue, incluso il giapponese, che io non capisco.
Mi siedo vicino a un finestrino e ti aspetti di intravedere la campagna. Anche se il film fosse ambientato a Tokyo, a un certo punto, su un certo treno, getterei lo sguardo su risaie terrazzate e piccole fattorie, oltre i tetti variopinti. Il paesaggio e il treno stesso sono uno spazio culturale nel cuore, una casa che tu, il pubblico, porti con te.
La ripresa aerea di New York nei film americani dovrebbe unirci allo stesso modo, ma così non è: non se, come me, non conosci la città. Forse sia i grattacieli di New York che le risaie giapponesi sono indirizzati a un pubblico universale. Forse, a differenza di me, gli spettatori giapponesi si fanno impazienti quando la cinepresa indugia sul paesaggio rurale. Ad ogni modo, ben presto il treno sprofonda in una galleria e non c’è più niente da vedere.
Arrivo in città, a San Francisco, e prendo le scale mobili fino in strada. In questo film giapponese, non c’è nessun autista di Uber di bell’aspetto con cui scontrarmi per caso mentre esco, ma neppure un senzatetto accampato ai miei piedi. Sei sorpreso di vedere che ha smesso di piovere, o che forse non pioveva su questo lato della baia. Nubi nere costellate di frammenti di sole scivolano nel cielo, agghindate per il centro città.
I dignitosi negozianti lungo Market Street abbassano le serrande delle loro botteghe; soltanto i franchising squallidi accendono le insegne al neon e si preparano all’arrivo dei salarymen ubriachi. Cammino spedita, determinata. La cinepresa coglie lo scintillio del tramonto sulla cupola del municipio e i piccioni sotto gli alberi potati di fresco. Strada facendo, non incontro nessuno che conosca per dare il via alla prossima scena. Devo entrare da sola nell’atrio di marmo dell’auditorium, dove mi attende la maestra di violino della mia infanzia.
La prima ripresa è di lei che siede da sola a leggere il programma. È una donna del tutto riservata, vestita di nero, con un corto caschetto grigio. Quando entro nell’inquadratura appaio goffa, troppo alta, con una ridicola camicia a fiori che rivelo sfilandomi la giacca blu scuro. Capisci immediatamente che non potrei mai saper suonare bene il violino. Ma la maestra si alza e mi abbraccia. In questo film giapponese, ti aspetti che ora si renda omaggio agli anni trascorsi insieme.
Lei, una volta all’anno, mi manda un invito al saggio degli studenti, a cui non partecipo. Io però le scrivo un biglietto in risposta, proponendo di incontrarci per un concerto. Quando ero bambina, fu lei a portarmi al primo concerto insieme ad altri allievi. Sedemmo sulla balconata e quando vidi i musicisti desiderai di volare giù e nascondermi tra loro, di appartenere alla musica. In un flashback, i miei compagni e io, con i capelli scuri e le divise blu, potremmo trasformarci in corvi dalle ali nero-bluastre: un tocco di realismo magico, un omaggio a un certo regista francese o italiano. Oppure no.
La maestra mi parla in inglese. Ti aspetti che si informi sulla salute di mia madre, ma sa che è morta qualche anno addietro. Non era un segreto che le lezioni fossero un’idea di mia madre e che io abbia sempre voluto smettere. La maestra ci capiva entrambe, persino allora: rispettava il sogno di mia madre di avere una figlia dotata di talento musicale e accettava il fatto che quella persona non fossi io. Durante le lezioni, dopo aver dato dimostrazione del mio simbolico impegno, suonava per me, o ascoltavamo dei dischi insieme. Si complimentava per il mio orecchio fino, così non mi ribellai alla musica. Quando lei e mia madre parlavano, non fingeva che stessi facendo rapidi miglioramenti, ma nemmeno si univa a lei nei rimproveri per non essermi esercitata.
Le chiedo di suo figlio, Hiroshi, di qualche anno più grande di me e che adesso tiene concerti come pianista. Dopo la mia domanda, un altro flashback: una ragazzina suona il violino in piedi accanto a una maestra tranquilla. È tardo pomeriggio e il pianoforte dietro di loro è in ombra, perché l’unica luce è sul leggio. (Guardando, più tardi, fremo alle aspre note suonate dalla ragazzina, ma le mie braccia non avvertono il peso dello strumento). Quando una porta sbatte, la ragazzina allontana il violino dal mento: compare un adolescente in uniforme scolastica che fa un inchino a sua madre e all’allieva. La sua tacita sicurezza inonda la scena e monopolizza la tua attenzione. La madre, sorridendo, piega il capo e la ragazzina, scombussolata, si inchina leggermente. Aspetta che se ne sia andato per sollevare di nuovo il violino.
La maestra risponde che Hiroshi è in tour per l’Europa. Aggiunge che c’è un nuovo nipote a New York. La cinepresa è tornata da noi nel presente e potresti stupirti di come il suo viso non sia vivace quanto la voce. Lui le manca.
Si sta bene in questo film. Tu, il pubblico, mi accetti come compagna di viaggio, non una stella del cinema. La maestra mi prende a braccetto mentre ci dirigiamo verso i nostri posti. Stasera ascolteremo Mahler sedendo in platea, una gioia per entrambe: nessuna delle due è tanto benestante da poter dare per scontati eventi come questo. Prima che la trama vada avanti, il regista potrebbe includere più parti del concerto di quante ti interessi sentire. È stato lui a prendere lezioni di violino da piccolo, non io.
Percepisci la familiarità delle due donne, la nostra umiltà, alla presenza dell’orchestra. Durante l’intervallo andiamo al bar a ordinare due bicchieri di champagne, la nostra spesa pazza come da tradizione. La maestra propone di brindare ai musicisti e, aggiungo io, alla fortuna che abbiamo di ascoltarli. Ci facciamo lentamente strada tra la folla fino alle pareti di vetro, da dove possiamo guardare giù in strada e osservare gli ombrelli aprirsi mentre comincia a piovere. La luce all’interno è dorata in confronto al grigio della strada. Sorseggiamo e sorridiamo. La cinepresa si trattiene sui nostri riflessi sul vetro finché l’alcol non ci ha arrossato le guance. È la sequenza preferita del regista.
La delicata euforia dello champagne si esaurisce prima che la seconda parte del concerto sia conclusa e mi agito nervosamente, sfregandomi le mani. Quando parte l’applauso è un sollievo perché sia tu che io abbiamo perso la cognizione dei movimenti, se quello fosse un adagietto o un andante moderato. La maestra e io ci mettiamo un po’ a scivolare tra la folla, dirette all’uscita. L’aria fuori è fredda e umida sui nostri visi, ma non c’è ancora pioggia forte da ombrello. È la sera di un giorno feriale e sto pensando al lavoro del giorno dopo quando la maestra, sospinta verso l’estremità del marciapiede, inciampa e cade sulla strada scivolosa.
Dice di star bene e si tira su col braccio che le porgo, ma non sta bene. Non riesce a poggiare il peso sulla gamba destra. Infine, una crisi. Accogli con piacere il suono dell’ambulanza in avvicinamento e le liquide luci rosse riflesse sull’asfalto bagnato. Per un istante, vorresti aver scelto un film hollywoodiano, uno con l’azione assicurata.
Dopo la corsa in ambulanza e la radiografia il medico, un’altra donna, mi rivela pacatamente che la maestra si è rotta l’anca.
La dottoressa dà un’occhiata al modulo di accettazione e chiede alla maestra se è il caso che chiamino suo figlio, indicato come contatto d’emergenza. All’inizio si oppone, non vuole disturbarlo. Ma la dottoressa le spiega che dopo l’intervento i pazienti non sono in grado di tornare a casa da soli perché camminare è ancora faticoso. Un’opzione è il ricovero – una struttura di riabilitazione – per fisioterapia intensiva. In altre parole, ci sono delle decisioni da prendere. La maestra è esausta e disorientata. Mi offro di telefonare.
Il cartello dice VIETATI I TELEFONI CELLULARI, quindi esco per un momento, una pausa da quella caotica agitazione. Nel parcheggio i puntini arancioni delle sigarette accese baluginano e si muovono insieme ai fumatori, come in una performance d’arte. A dir la verità, il regista ha chiesto anche a me di fumare, ma mi sono rifiutata. Invece cerco riparo sotto il tetto aggettante dell’edificio perché la pioggerella non smette e faccio respiri profondi prima di provare a telefonare. C’è un’enorme differenza di fuso orario con la Svizzera e Hiroshi non capisce chi sia finché non ammetto con riluttanza di essere l’allieva del mercoledì che suonava malissimo. Sei dispiaciuto per me.
L’intervento è previsto per la mattina. Gli spiego il programma per come l’ho capito. No, non un ospizio, la dottoressa ce l’ha assicurato e io l’assicuro a Hiroshi, benché non sia poi tanto certa della differenza tra «struttura di riabilitazione» e ospizio e lui se ne accorge. Fa domande ansiose fino a quando non ammetto di fidarmi della dottoressa perché ha i biglietti per il concerto di Mahler della sera dopo, poi sospira.
La maestra e io trascorriamo quasi tutta la notte al pronto soccorso: lei, quando non si muove o lamenta, russando dolcemente sulla barella; io, seduta al suo fianco, cerco di rimanere abbastanza sveglia da fare la guardia alle nostre borse e controllare che non ci siano sviluppi. È l’occasione giusta per una sfilata di personaggi secondari e infermiere baldanzose. C’è sempre un tizio della Yakuza in canottiera con enormi braccia tatuate nei film di questo regista. Pensavo che sarebbe apparso in questa scena, ma non lo vedo. Vedo un ragazzo diafano, reso calvo dalla chemioterapia, e un corpulento poliziotto nero, la camicia dell’uniforme tirata fuori a coprire cintura e fondina. Rimango con la maestra mentre la trasferiscono in una camera e aspetto fino all’alba, quando la portano via per l’intervento. Sono costernata da quanto sembri vecchia sotto le luci impietose. Poi mi trascino di nuovo fino alla BART.
Il regista non mi segue subito fino al mio appartamentino. È una buona scelta, dato che ho bisogno di dormire. Ho apprezzato anche che qui la sceneggiatura non mi richiedesse di dar da mangiare a un gatto: non sono quel tipo di donna. Alla fine vedrai il mio appartamento attraverso lo sguardo di Hiroshi, il suo biasimo per le sbarre alla finestra della cucina e l’assenza di strumenti musicali.
Quando arriva, trentasei ore più tardi, sono al capezzale di sua madre. Ha la gamba in uno strano marchingegno, tenuta sollevata dopo l’operazione. In questo film giapponese, le camere d’ospedale non sono rosa e imbottite di cuscini, ma arredate in modo essenziale, con letti stretti e sedie dallo schienale diritto. Sua madre si è appisolata e siamo entrambi restii a svegliarla, perciò non parliamo. Ora che ha un’aria distinta ed è sposato è meno alla mia portata che mai, ma all’ospedale nessuno ci conosce e danno per scontato che siamo una coppia. È il figlio e io sto con lui.
Mentre la madre dorme andiamo al bar per un caffè, e sospetti, dal modo in cui i suoi occhi mi seguono, che fisseremo un appuntamento per rivederci. Non ti sbagli. Nel bar la luce si rifrange sul lucido del linoleum e della fòrmica, sui suoi capelli lucenti. Di nuovo, la gente parla in molte lingue: il regista ha in mente una San Francisco poliglotta. Un bambino piange al di sopra del baccano indistinto e Hiroshi e io ci facciamo più vicini.
Studio il suo volto stanco, la consistenza della giacca di lana. È la persona più famosa che conosca, eppure siamo due sconosciuti. La nostra conversazione incerta rasenta torbide sponde di solitudine e dislocamento. A un certo punto chiudi gli occhi per rilassarti nella pacatezza della sua voce. Quando li riapri, la bambina che ha smesso di piangere compare nell’inquadratura, il viso gonfio, i capelli in disordine. La guardiamo insieme a te.
Ho la borsa della madre, con le chiavi di casa sua, e lui dall’ospedale non sa come arrivarci. Quindi ci andiamo insieme. Apre la porta mentre aspetto in veranda, come ero abituata ad aspettare che l’allievo prima di me avesse finito. Dentro non è cambiato nulla. La custodia del violino è nell’ingresso, insieme a una borsa di libri di musica, a portata di mano della maestra uscendo di casa. Intorno all’enorme pianoforte a coda in sala, leggii assiepati come scheletri di compagnia. Mi accomodo su una sedia, il mio posto, non sul divano, il posto di mia madre. Il regista ti costringe ad aspettare insieme a me, incerto se Hiroshi mi chiederà di restare. Lo sentiamo far scorrere l’acqua, aprire porte. Infine mi richiama e mi rimetto in piedi, sostenendomi a un lato del pianoforte.
Lascia che ti avverta: alla fine confesso la mia cotta infantile. Nel contratto ho acconsentito a spogliarmi, eppure in questo tipo di film non si può contare sul sesso senza vestiti, persino con questo potenziale partner adatto alla mia età. Lottiamo contro i nostri sentimenti contrastanti e non capirai se ci innamoreremo o se non ci rivedremo più, o entrambe le cose.
Ciascun esito, la fioritura e il bocciolo appassito, è altrettanto plausibile. I nostri sentimenti sono complicati e non esistono esplicite convenzioni sociali prestabilite. Non ci sono neanche dei migliori amici che possano spiegarci le nostre emozioni. Come te, posso soltanto leggere il viso di Hiroshi e ascoltare le sue parole. Concentrarsi è come nuoto sincronizzato per aria, una lenta danza aerea senza rete.
Se tutto il resto dovesse fallire, la cinepresa andrà alla ricerca di ordine e bellezza per confortarti: Hiroshi in boxer di cotone e t-shirt bianchi che suona Chopin, uova bianche allineate sul ripiano della cucina, ombre di alberi all’esterno.
Mi metto a sua disposizione per i due giorni in cui si trattiene. Per lo più lavoro da casa comunque e questo è uno di quei film, un intervallo estemporaneo. Deve avere dei legami in città, amici con cui è cresciuto, musicisti, ma non li contatta.
Lo accompagno in macchina fino alla struttura di riabilitazione e la visito con lui, facendo le domande che farebbe una donna, sul bucato e il cibo. Lui chiede della fisioterapia. Passeggiamo in giardino, le rose a malapena verdeggianti, placche commemorative su ogni albero o panchina.
«Solo per una settimana o poco più» ripete.
Annuisco.
L’indomani tardano a trasferire sua madre e dobbiamo partire per l’aeroporto prima che lei arrivi. Sarà delusa di non rivederlo. Al terminal, quando lo accompagno, prometto di tornare subito indietro per vedere come sta. Lui esita con la portiera aperta, ma il poliziotto mi sta già facendo cenno di procedere.
Tornare alla struttura da sola non è la stessa cosa. All’inizio non capivo perché il regista volesse che restassi in macchina, le mani sul volante, una volta parcheggiato. Ma puoi vedere che è un buon momento, aveva ragione. Guardo diritto verso la cinepresa, stordita ed esausta.
Quando trovo la sua stanza, la maestra sta piangendo sommessamente. Non le chiedo perché, ma dice che il viaggio era scomodo e che c’è stato un ritardo nel somministrarle gli antidolorifici. Glieli hanno appena dati. Mi siedo accanto al letto e le prendo la mano, che è fredda. Armeggio con la borsa dei suoi effetti personali e trovo una vestaglia, gliela metto sulle spalle. Mi ringrazia per essere venuta, per tutto il mio aiuto. La ringrazio per essere stata paziente con me quand’ero bambina e ride: i farmaci sono entrati in circolo.
Siamo in pausa dalle riprese, adesso. Mi aspetto che la maestra si rimetta, la scena finale potrebbe riportarci all’auditorium a distanza di anni, ma potrebbe anche sorgere una complicazione inaspettata e la scena svolgersi in un cimitero, Hiroshi e io sulla tomba di sua madre sotto un ciliegio in fiore. Forse il tipo della Yakuza è al funerale insieme a noi. Prendeva lezioni di violino, una volta. Un film giapponese di questo tipo è imprevedibile, a eccezione del fatto che i fiori di ciliegio simboleggiano la fragilità e la bellezza della vita.
Approfitto del tempo per guardare altri film giapponesi. Mentre scorrono i titoli di coda, mi interrogo su ciò che ho visto, se le loro storie fossero sufficienti per un film, e immagino come ti sentirai guardando il nostro. Spero che lo troverai perfetto. Sarebbe d’aiuto se traducessero le parole della canzone struggente che risuona sui titoli di coda.
Nella tua recensione online, forse lamenterai il ritmo troppo lento, che la storia divagava e che non sapevi cosa aspettarti. Potresti accusare il regista di flirtare con l’indecifrabile. Ma prevedo almeno tre stelle, perché ci saranno dei momenti d’impatto. Hai anche bevuto champagne non sapendo cosa avesse in serbo la notte.
E tu, infine, apprezzi la rivelazione di una vita minuscola, irrisolta.
*
Titolo originale, Director’s Cut, copyright @ Toni Martin, all rights reserved.
Traduzione di Serena Stagi.

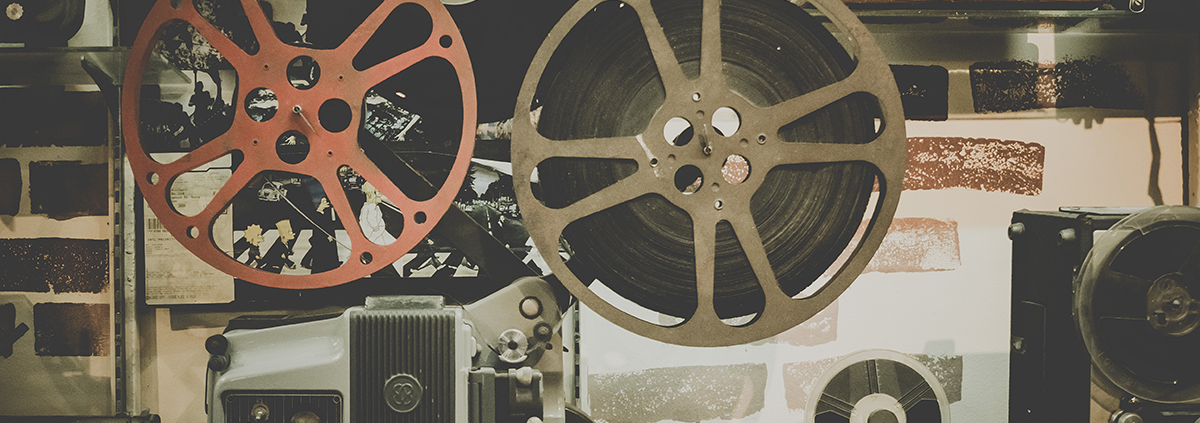




 @John Peters
@John Peters 

